Materiali intelligibili
ŌĆ£Le predette sostanze, che abbiamo chiamate immateriali, devono essere anche intellettuali. Infatti una cosa ├© intellettuale in quanto ├© immune dalla materia, come si pu├▓ percepire dallŌĆÖintelligibile stesso.ŌĆØ (Tommaso DŌĆÖAquino)
Ne LŌĆÖascesa allŌĆÖempireo (1504) Hyeronimus Bosch descrive un gruppo di anime che si eleva verso il paradiso: perdendo sensibilmente le costrizioni del peso corporeo, giungono ad un cilindro luminoso alla cui sommit├Ā si scorgono le ombre dei beati intenti a compiere lŌĆÖultimo sforzo prima di ascendere alla contemplazione divina. La tela ├© ancora oggi sorprendente. Con unŌĆÖinconsueta economia di mezzi il pittore ha rappresentato in un modo estremamente realistico unŌĆÖesperienza mistica, ponendo una grande attenzione tanto nel sottolineare lo sgravarsi dai corpi quanto nel dare una dimensione astratta alla luce divina. Fisicit├Ā e luce, due caratteristiche che denotano il concetto di trasparenza legato ad unŌĆÖesperienza di ordine mistico, almeno sino allŌĆÖavvento della tecnologia e dellŌĆÖintroduzione delle materie plastiche allŌĆÖinterno della ricerca visiva delle avanguardie. Innovazione e concezione materialistica degli strumenti, cui occorre aggiungere per├▓ quel grado di intellegibilit├Ā che ricordava lŌĆÖAquinate; quel grado cosciente di concettualit├Ā tanto caro al secolo appena concluso.

 Un rispecchiamento fattivo di tipo concettuale che verr├Ā un ventennio pi├╣ tardi ribadito da Dan Graham che nel 1982 realizza Two Adjacent Pavillons. Si tratta di due moduli ricoperti in ogni lato da un vetro specchiante; uguali, possono essere fruiti sia dallŌĆÖinterno che dallŌĆÖesterno della struttura. La diversit├Ā ├© nel soffitto: in vetro trasparente uno e di un materiale scuro che non lascia passare la luce lŌĆÖaltro. Le propriet├Ā del vetro specchiante fanno s├¼ che in qualsiasi momento ciascun lato sia pi├╣ trasparente o riflettente dellŌĆÖaltro. Durante la fascia diurna, il soffitto in materiale opaco non permette alla luce solare di illuminare lŌĆÖinterno di un padiglione: chi ├© fuori non vede nulla dentro ma si vede specchiato nei vetri insieme allŌĆÖambiente circostante. NellŌĆÖaltro padiglione il sole colpisce direttamente le pareti interne, che cos├¼ che riflettono pi├╣ luce di quelle esterne; chi ├© fuori vede bene lŌĆÖinterno, ma chi ├© dentro vede soprattutto la propria immagine riflessa nei vetri. ŌĆ£Diversamente dalle strutture formaliste della minimal art situate allŌĆÖaperto, i padiglioni sono psicologicamente e socialmente autoriflettenti. Implicano una dialettica tra spettatori ed immagine che essi hanno di s├®ŌĆØ, dichiara lŌĆÖartista. Di tuttŌĆÖaltra radice la ricerca intrapresa da Eva Hesse in cui gli oggetti sono costruiti sulla frammentazione e dispersione di ogni concetto di univocit├Ā e fissazione. Il principio di indeterminazione prefigurato in Repetition Nineteen III del 1968 costituito in 19 elementi traslucidi in fibra di vetro, a forma di bizzarri ed irregolari ŌĆśbicchieriŌĆÖ, da disporre liberamente a pavimento, a prescindere da un ordine predefinito, trova pieno compimento allŌĆÖinterno di una poetica dove il lattice, filamenti in poliestere e fibre artificiali, seguono una precisa configurazione organica e vitalistica.
Un rispecchiamento fattivo di tipo concettuale che verr├Ā un ventennio pi├╣ tardi ribadito da Dan Graham che nel 1982 realizza Two Adjacent Pavillons. Si tratta di due moduli ricoperti in ogni lato da un vetro specchiante; uguali, possono essere fruiti sia dallŌĆÖinterno che dallŌĆÖesterno della struttura. La diversit├Ā ├© nel soffitto: in vetro trasparente uno e di un materiale scuro che non lascia passare la luce lŌĆÖaltro. Le propriet├Ā del vetro specchiante fanno s├¼ che in qualsiasi momento ciascun lato sia pi├╣ trasparente o riflettente dellŌĆÖaltro. Durante la fascia diurna, il soffitto in materiale opaco non permette alla luce solare di illuminare lŌĆÖinterno di un padiglione: chi ├© fuori non vede nulla dentro ma si vede specchiato nei vetri insieme allŌĆÖambiente circostante. NellŌĆÖaltro padiglione il sole colpisce direttamente le pareti interne, che cos├¼ che riflettono pi├╣ luce di quelle esterne; chi ├© fuori vede bene lŌĆÖinterno, ma chi ├© dentro vede soprattutto la propria immagine riflessa nei vetri. ŌĆ£Diversamente dalle strutture formaliste della minimal art situate allŌĆÖaperto, i padiglioni sono psicologicamente e socialmente autoriflettenti. Implicano una dialettica tra spettatori ed immagine che essi hanno di s├®ŌĆØ, dichiara lŌĆÖartista. Di tuttŌĆÖaltra radice la ricerca intrapresa da Eva Hesse in cui gli oggetti sono costruiti sulla frammentazione e dispersione di ogni concetto di univocit├Ā e fissazione. Il principio di indeterminazione prefigurato in Repetition Nineteen III del 1968 costituito in 19 elementi traslucidi in fibra di vetro, a forma di bizzarri ed irregolari ŌĆśbicchieriŌĆÖ, da disporre liberamente a pavimento, a prescindere da un ordine predefinito, trova pieno compimento allŌĆÖinterno di una poetica dove il lattice, filamenti in poliestere e fibre artificiali, seguono una precisa configurazione organica e vitalistica.
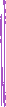

Per Kapoor la qualit├Ā di superficie ├© una fonte infinitamente investigabile: "La pelle, la superficie esterna, ├© sempre stata per me il posto dell'azione. ├ł il momento di contatto tra l'oggetto e il mondo. La pellicola che separa l'interno dall'esterno." LŌĆÖepidermide ├© per l'artista anglo-indiano, il momento della tensione e dell'azione dell'opera; ├© il luogo nel quale avvertiamo il cambiamento. Le opere sono configurazione di oggetti o meglio luoghi, invadono lo spazio e lo assorbono fino a renderlo parte dell'opera stessa. Tra le coppie di opposti quella interiore/esteriore, gioca un ruolo molto importante, soprattutto alla luce del crescente interessamento da parte dell'artista verso il tema della rivelazione e dissimulazione. Lavora con le superfici riflettenti, per le creazioni di specchi deformanti o che addirittura annullano l'immagine stessa, come in Double Mirror, 1997; o che la inghiottono verso un limite vertiginoso come in Turning the World Upside Down, 1995 o Suck, 1998. "Il mio lavoro ├© una lotta, un inarrestabile combattimento", dichiara. Le sue opere hanno a che fare con la materia, la trasformano, la deformano, nel senso letterale di privare di una forma che sia fisica. Tutta la grande produzione dell'artista di questa fase consiste nella messa in scena del vuoto, un vuoto reso tangibile da una cavit├Ā che si riempie o da una materia che si svuota. L'opera di Kapoor consiste nella rivelazione di un'apparizione interna, innata alla materia, in un farsi originario dell'opera, verso la messa in scena di una realt├Ā profonda, avvertibile in una transizione, in un passaggio, in una visione diagonale. Essa ├© un grande specchio deformante pronto a mettere in scena il tempo dell'esperienza, riflettendo la natura in una superficie unica. 
Una speculazione sensitiva differente, il rimando alle cose per la conoscenza intima del mondo, lŌĆÖanalogia come ductus descrittivo invece per Dacia Manto che varca la sapienza tattile della natura, ne trae lŌĆÖessenza, il contenuto, attraverso lŌĆÖesercizio e la manualit├Ā dellŌĆÖesecuzione, il lento costruire e manifestarsi, quasi musicale, delle cose. Un impercettibile ritmo, una partitura organica diventa codice di stile, elemento caratterizzante di definizione per una pratica operativa pauperistica nei materiali ma spesso barocca e virtuosistica nei suoi assunti. La luce in tale economia risulta referente privilegiato, annotazione di un flusso primario, vibrante, costitutivo in quanto simbolo di una energia recondita pulsante.
Una prospettiva rizomatica quella di Manto, in moto perpetuo fra organicismo e fisiologia, condotta secondo modalit├Ā lievi. Come afferma Novalis, filosofo prossimo alle istanze fin qui osservate, ŌĆ£il poeta conclude nel modo in cui egli comincia lŌĆÖimpulso. Se il filosofo si limita a ordinare, disporre, il poeta sciolga ogni legame. Le sue parole non sono segni generali ŌĆō sono suoni ŌĆō parole magiche, che muovono attorno a s├® belle schiere.ŌĆØ

